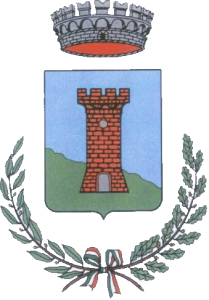«Dalla mia casa, alta sul colle di Parella, io vedo ad ogni volger d’occhio la Cartiera, il nostro antico Batùr fumante, laggiù, in fondo ai bassi prati della Torrazza» scrive nel 1942 Francesco Carandini, auspicando che la gloriosa fabbrica possa arrivare a festeggiare i suoi cinque secoli di vita.
La «fondazione di un battitore di carta» a Parella, in regione Sarro, sul greto del torrente Chiusella, risale al 1477 a opera dei fratelli Raynero e Gaspare San Martino, signori del luogo e del Castello, nei cui beni rientra la struttura produttiva. Nel 1733 un’esondazione del torrente danneggia gravemente gli impianti che, l’anno seguente, vengono ricostruiti nell’attuale ubicazione, in regione Gimona, subendo nel tempo diverse trasformazioni e ampliamenti. Gli interventi più consistenti e tecnicamente innovativi datano all’inizio della gestione Bosso, negli anni 1885-99, come ricorda la lapide che permane fra il corpo con la torretta e il capannone “a botte”.

Nel 1885, dopo la chiusura per il fallimento dichiarato due anni prima dall’avv. Martinazzi De Ambrosis, proprietario della Cartiera, nella conduzione era infatti subentrato Giacomo Bosso (1854-1936), che aveva riavviato la produzione. Egli commissiona quindi opere edilizie che conferiscono alla struttura un impianto grossomodo a due corpi allungati paralleli, separati da una corte e orientati in direzione nord-ovest, nel tipico stile essenziale dei fabbricati industriali del tempo. Sorgono allora la ciminiera e la torretta, il cui skyline connota tuttora il complesso. Risale al 1897 l’esordio di solai e pilastri in conglomerato cementizio armato Sistema Hennebique nel capannone di sud-est, detto “a botte” per la copertura arrotondata. Il progetto di quest’innovativa soluzione tecnologica «incombustibile », che consente grandi luci senza bisogno di sostegni intermedi, è siglato dall’ing. Giovanni Facchini (1873-1942), al cui padre il cav. Bosso è fraternamente legato. Egli converte quindi il vetusto mulino da cereali in reparto di lavorazione degli stracci, perfeziona gli impianti con nuove turbine e macchine per la preparazione dei composti ed è tra i primi in Italia a inserire la cellulosa negli impasti della carta da pacchi. Amplia inoltre l’attività introducendo nell’azienda lavorazioni di carte calandrate e di vari preparati per cartotecnica. Si affaccia così sul mercato internazionale con esportazioni di alta qualità, che nel 1900 gli valgono una medaglia d’oro all’Esposizione universale di Parigi.
Nel 1906 nasce la Società Anonima Cartiere Giacomo Bosso, di cui lo stesso intestatario è presidente e amministratore delegato. Nel 1912 il cav. Bosso lascia però la guida della Cartiera per disaccordi con la proprietà. Gli subentra la ditta Carlo Slatri & C., in società con i fratelli Antonio e Giovanni Giacosa, che gestiscono la produzione sino alla chiusura, nel 1927. Gli impianti sono riattivati nel 1931 da Melchiorre Benini con scarsi risultati. In forza di acquisto, il complesso produttivo torna nel 1933 al gruppo Cartiere Giacomo Bosso, titolare dell’attività sino alla serrata definitiva, nel 1960 circa, senza che la grande Cartiera, per secoli luogo di lavoro e veicolo di benessere in Pedànea e circondario, possa arrivare a festeggiare gli auspicati cinque secoli di vita.

Giacomo Bosso (Chivasso, 1854 – Torino, 1934) entra a tredici anni come garzone in un negozio di carta a Torino; diviene apprendista e quindi, a circa vent’anni, viaggiatore commerciale. Dopo avere accumulato un’ampia esperienza del mercato cartario in Italia, assume la direzione della Cartiera di Parella e nel 1894 acquista la Cartiera di Torre Mondovì, aggregando in seguito anche le Cartiere di Mathi Inferiore e Superiore. Partecipa attivamente alla vita politica e all’alta finanza subalpina, assumendo la carica di sindaco di Colleretto Parella (1892-94), presidente della Camera di commercio di Torino. Collabora con Agnelli, L. Bonnefon-Craponne, Emilio De Benedetti e altri imprenditori alla nascita della Lega industriale di Torino (1906), assumendone la vicepresidenza. Nello stesso 1906 è nominato Cavaliere del Lavoro e dal 1893 era Cavaliere della Corona d’Italia. Continua frattanto la sua ascesa politica, culminata con la nomina a rettore della Provincia di Torino. La sua palazzina, dotata di dipendenze e serra, permane a Colleretto Giacosa, ai nn. 3-5 della Provinciale, e si caratterizza per l’impianto a “L”, a due piani e comodo sottotetto, nel medesimo stile delle addizioni operate a fine ‘800 nella Cartiera.
Scheda tecnica a cura dell’arch. Grazia Imarisio